
Le operazioni di acquisizione di società quotate in borsa rappresentano uno dei pilastri fondamentali del mercato finanziario italiano. Uno degli strumenti cardine per questa tipologia di acquisizioni è rappresentato dall’Offerta Pubblica d’Acquisto, un processo regolato in Italia da precise norme di legge. Ma cos’è l’OPA? È il meccanismo con cui soggetto propone agli azionisti di una società di vendere le loro azioni a un prezzo prestabilito, ad esempio per acquisirne il controllo, per consolidamento o delisting. Regolata dal Testo Unico della Finanza, come funziona e quali regole deve rispettare?
Cosa si intende per OPA
L’OPA - ovvero l’Offerta Pubblica d’Acquisto - è un’operazione finanziaria regolata dal Testo Unico della Finanza, ovvero dal D.Lgs. 58/1998. Così come già accennato in apertura, si tratta di una proposta pubblica rivolta a tutti gli azionisti di una società quotata in borsa, con cui l’offerente chiede di:
- poter acquistare tutte le azioni a un prezzo determinato;
- concludendo l’operazione in un lasso di tempo prestabilito.
In linea generale, le OPA in Italia vengono effettuate per consolidare una posizione all’interno di una società o, ancora, per acquisirne il completo controllo. Ancora, si può ricorrere all’Offerta Pubblico d’Acquisto anche per delistare una società dalla borsa, ovvero rimuoverla dalla quotazione.
La differenza tra OPA, OPAS e OPS
L’OPA non è però l’unica operazione finanziaria di questo tipo ammessa sul mercato italiano e regolata dal TUF: per questa ragione, è utile distinguerla sia dalla OPAS che dall’OPS. Ma quali sono le differenze principali? In linea generale:
- l’OPA, come già visto, è l’operazione in cui un offerente propone agli azionisti di acquistare le loro azioni a un prezzo determinato, con l’obiettivo di raggiungere un controllo rilevante, o totale, della società;
- l’OPAS, ovvero l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio, combina il pagamento con l’offerta di azioni o di altri strumenti finanziari, in modo che gli azionisti possano scegliere tra la liquidità e la partecipazione alla nuova entità;
- l’OPS, cioè l’Offerta Pubblica di Scambio, riguarda il semplice scambio di azioni senza una componente in denaro, ed è perlopiù utilizzata per le integrazioni della società.

Come già affermato, le tre operazioni sono regolate dal Testo Unico della Finanza e sono sottoposte all’attività di vigilanza della Consob - la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - affinché vengano concluse con trasparenza e nella massima tutela degli azionisti.
Chi può lanciare un’OPA
Sono diversi i soggetti che possano lanciare un’Offerta Pubblica d’Acquisto verso gli azionisti di una società. In linea generale, possono procedere:
- una persona fisica;
- una società;
- un fondo d’investimento;
- qualsiasi soggetto giuridico che dispone delle risorse finanziarie idonee.
L’offerente dovrà presentare un documento d’offerta, dove verrà dettagliato il prezzo, le modalità d’acquisto delle azioni e le finalità dell’operazione, in base a quanto previsto dall’articolo 102 del TUF. Come già spiegato, l’intera operazione è sottoposta alla vigilanza della Consob, che controlla la conformità dell’offerta alle normative vigenti.
Le tipologie più comuni di OPA
Per comprendere pienamente il funzionamento e i meccanismi dell’Offerta Pubblica d’Acquisto, è innanzitutto necessario distinguerne le principali tipologie, poiché possono avere sia origini che esiti diversi.
Cos’è l’OPA volontaria
Tra le principali tipologie, l’OPA volontaria rappresenta di certo una delle più diffuse. Si tratta di un’Offerta Pubblica d’Acquisto che viene proposta liberamente dall’offerente, per acquisire una partecipazione significativa di una società.
In linea generale, questa OPA non prevede vincoli di adesione per gli azionisti: di solito, viene scelta per acquisire una porzione rilevante di una società o, ancora, preparare il terreno per una futura acquisizione totalitaria.
Cosa si intende per OPA obbligatoria
Spesso si sente parlare anche di OPA obbligatoria, che scatta quando un soggetto acquisisce una percentuale superiore al 30% del capitale sociale della società. In questo caso, come previsto dall’articolo 106 del TUF, l’offerente è obbligato a lanciare un’OPA su tutte le azioni ordinarie residue, affinché gli azionisti possano venderle a un prezzo equo.

Si tratta di un meccanismo nato soprattutto a protezione dei piccoli azionisti che, a causa dell’acquisizione, potrebbero rimanere svantaggiati sotto il nuovo controllo.
A cosa serve l’OPA totalitaria
Cos’è l’OPA totalitaria, invece? È un’offerta volta ad acquisire la totalità delle azioni di una società, così come suggerisce il nome. Può essere volontaria o obbligatoria e, di solito, viene effettuata quando l’offerente desidera delistare la società dalla borsa. Inoltre, se l’offerente raggiunge almeno il 95% del capitale, può esercitare il diritto d’acquisto coattivo delle azioni residue, in base all’articolo 111 del TUF.
I principi dell’OPA residuale
Per OPA residuale si intende invece un’offerta obbligatoria che segue un’OPA totalitaria. In questo caso, l’offerente ha acquisito una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95%: in questo modo, si offre agli azionisti rimanenti un’ulteriore possibilità di vendere le proprie azioni a prezzo equo.
Cosa prevede l’OPA ostile
Ancora, si verifica un’OPA ostile quando l’offerta è lanciata senza che vi sia il consenso del consiglio d’amministrazione della società che si intende acquisire. Si tratta di un’operazione che spesso è finalizzata a sostituire il management esistente o, ancora, prendere il controllo di una società senza che quest’ultima ne sia d’accordo.
Cos’è l’OPA preventiva
Fra le tante tipologie, cos’è l’OPA preventiva? Si tratta di un’OPA volontaria, nota nella prassi come “preventiva” perché mira a raggiungere una partecipazione fino alla soglia del 30% per evitare un’OPA obbligatoria. In altre parole, l’offerente propone un determinato prezzo agli azionisti allo scopo di acquisire una partecipazione rilevante, mantenendo però il suo controllo sull’azienda sotto a una soglia critica.
L’OPA di consolidamento: cos’è e a cosa serve
È utile considerare anche l’OPA di consolidamento, che solitamente viene lanciata da un azionista che già detiene una partecipazione significativa nella società, in genere già superiore al 30%. In questo caso, viene avviata per incrementare la propria quota, così da acquisire maggiore controllo: una soluzione spesso scelta per rafforzare la governance o, ancora, in preparazione di una futura OPA totalitaria per delistare la società in borsa.
Cos’è l’OPA successiva totalitaria
Infine, è utile anche ricordare anche l’OPA successiva totalitaria, così definita nella prassi quando promessa a seguito di una precedente OPA obbligatoria o volontaria. Anche in questo caso, l’obiettivo è arrivare a ottenere il 100% delle azioni della società.
Cosa succede in caso di OPA
Spiegato cosa sia l’Offerta Pubblica d’Acquisto, chi possa lanciarla e quali siano le tipologie più diffuse, è utile comprenderne il processo. In altre parole, cosa succede in caso di OPA?

Il processo si distingue in diverse fasi, con il primo passaggio rappresentato dall’annuncio dell’OPA: l’offerente comunica pubblicamente le sue intenzioni, specificando il prezzo offerto per azione e il periodo di adesione, di solito tra 15 e 40 giorni. Il prezzo dovrà essere equo e, in caso di un’OPA obbligatoria, non inferiore al prezzo più alto pagato dall’offerente per le stesse azioni nei 12 mesi precedenti.
A questo punto, si sviluppano due fasi successive:
- l’approvazione da parte della Consob, che ne verifica la correttezza e la completezza;
- l’adesione degli azionisti, che decidono se accettare l’offerta - e quindi vendere le loro azioni - o di rifiutarla. In caso di OPA totalitaria o residuale, come visto, vi possono essere situazioni in cui l’offerente può esercitare il diritto d’acquisto delle azioni residue.
L’ultima fase è quello dell’esito dell’Offerta Pubblica d’Acquisto: allo scadere delle tempistiche previste, l’offerente comunica i risultati. Qualora l’OPA non abbia avuto esito soddisfacente, l’offerente può sia decidere di rilanciarla che, al contrario, di ritirarsi.
È infine bene ricordare che l’Offerta Pubblica d’Acquisto può avere delle conseguenze importanti, sia per le società che per gli azionisti:
- può portare a un cambio di controllo, o nuovi equilibri aziendali, che possono sfociare in rinnovate strategie di borsa per la società o, ancora, al delisting dal mercato azionario, come spesso accade per le OPA totalitarie;
- può offrire agli azionisti la possibilità di monetizzare le proprie azioni a un valore spesso superiore a quello di mercato, ma può portare anche a una perdita di valore, in caso di rifiuto dell’offerta.
In definitiva, l’OPA può presentare sia vantaggi che svantaggi, per le società e per gli azionisti, di conseguenza è sempre necessaria una profonda valutazione prima della sua sottoscrizione.


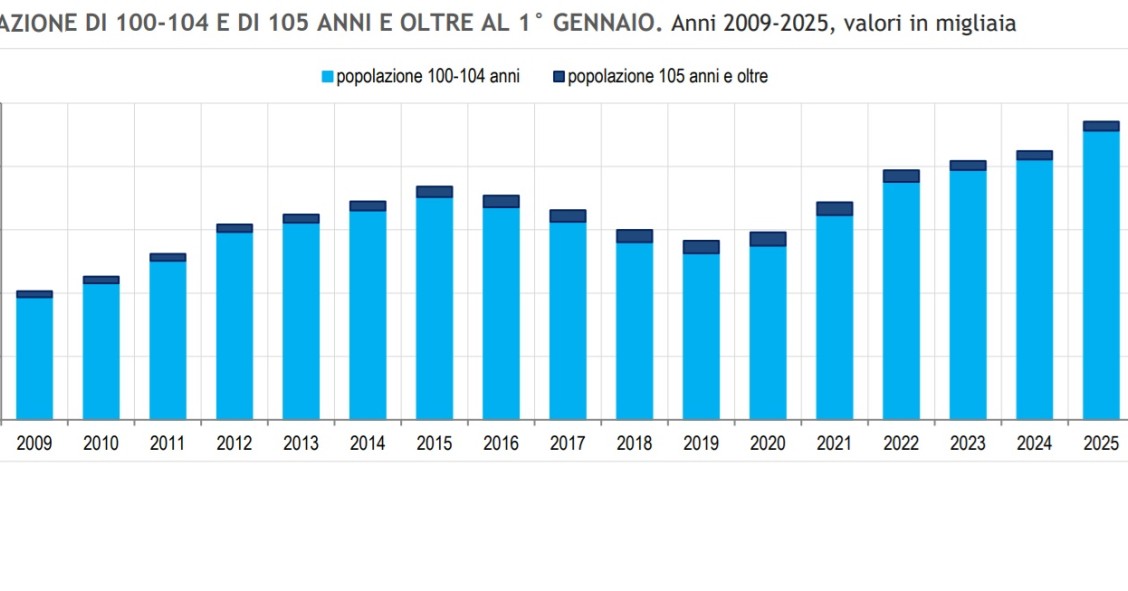





per commentare devi effettuare il login con il tuo account