
Nella caotica uscita dalla pandemia da Covid19, e dai suoi effetti su tutta l’economia, tra le numerose difficoltà che le famiglie italiane si stanno trovando a fronteggiare vi è l’impennata delle bollette di luce e gas. La crisi energetica 2021 tuttavia non riguarda solo l’Italia, ma anche il resto d’Europa e le cause sono molteplici. Secondo gli addetti ai lavori il problema è destinato a durare per tutto l’inverno fino a primavera inoltrata del 2022.
La crisi energetica attuale
Fin da subito occorre fare una premessa: come tutti i fenomeni di ampia portata, alla base di questo aumento vi è una serie disolo in parte riconducibili alle ricadute economiche della pandemia. fattori
In generale, la scintilla che ha fatto scatenare la crisi è stata la ripresa della domanda di carbone, petrolio e gas naturale dopo il calo dovuto alla pandemia da coronavirus, che ha rallentato la produzione industriale un po’ ovunque. Ad accentuare le difficoltà di approvvigionamento di energia hanno poi contribuito i grandi problemi di logistica e distribuzione causati dalla pandemia.
In sintesi, i paesi produttori di petrolio e gas naturale, che è costituito da una miscela di gas, composta quasi interamente da metano (per intenderci il gas che utilizziamo in cucina), non sono riusciti ad aumentare l’offerta necessaria per soddisfare la crescita della domanda e quando la domanda di un bene scarso cresce, secondo le leggi del mercato, a crescere sono anche i prezzi. Ma il bene, in questo caso gli idrocarburi, era già scarso.
Nell’Unione europea in particolare le riserve sono ai minimi storici dal 2013. E nei prossimi mesi, con l’avanzare dell’inverno, ci sarà un ulteriore aumento della domanda per l’uso dei sistemi di riscaldamento.
In questo caso non vale però il detto “mal comune mezzo gaudio”, perché ogni Paese attinge alle risorse energetiche disponibili in modo diverso e pertanto la crisi energetica non dispiega i suoi effetti in modo uniforme. In molti paesi dell’Unione europea, Italia compresa, il problema principale è il gas: più del 20 per cento dell’energia elettrica prodotta nei paesi dell’Unione è ottenuta dal gas naturale (in Italia circa il 40 per cento). Quasi tutto il gas è importato: circa il 90 per cento proviene da paesi non membri, di cui poco meno della metà (il 43,6 per cento nel 2020) arriva dalla Russia.
“Tutti nel Continente hanno un problema con le bollette”, ha spiegato a Il Messaggero Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ma ci sono “Stati più al riparo, perché più ricchi, perché hanno più risorse oppure perché hanno la struttura del sistema energetico più riparata. L’esempio tipico è la Francia, che usa per il 70% il nucleare. La Germania è un Paese ricco e usa molte rinnovabili. Certo, sta soffrendo perché non c’è vento, ma quest’anno ha aumentato del 50% l’uso del carbone: ha addirittura riaperto le miniere di lignite. Noi in Italia abbiamo solo gas, abbiamo chiuso le centrali a carbone e quest’anno abbiamo aumentato del 50% le importazioni di energia elettrica dall’estero”.
Tante cause per un problema complesso
Data la corsa all’accaparramento di combustibili fossili, chi è in grado di fornirlo sa di trovarsi in una posizione di forte vantaggio: è il caso della Russia che negli ultimi mesi ha ridotto i flussi di gas che riforniscono l’Europa attraverso i gasdotti che passano da Bielorussia, Polonia e Ucraina. Per quanto il governo del Paese abbia dovuto sostenere maggiori richieste da parte dei paesi asiatici, dato che la crisi energetica si sta rivelando un problema globale, l’ipotesi più verosimile è che la riduzione delle forniture all’Europa sia finalizzata ad ottenere l’attivazione del Nord Stream 2, un grande gasdotto che passa sotto il mar Baltico e raggiunge direttamente la Germania ma che ha sollevato le preoccupazioni dei Paesi dell’Europa Orientale (a causa della riduzione delle entrate da tasse per il passaggio del gas dai loro territori).
A rendere la situazione più complessa è il venir meno di alcune fonti energetiche: i giacimenti di gas del mare del Nord sono sempre meno produttivi. I Paesi Bassi, a causa di rischi sismici, stanno procedendo per esempio con la chiusura del giacimento di Groningen, grazie a cui fino a due anni fa erano, insieme alla Danimarca, gli unici esportatori netti di gas nell’Unione Europea.
Nei paesi nordici un’estate particolarmente priva di vento e secca ha fatto scendere ai loro livelli minimi da più di un decennio i bacini che alimentano le centrali idroelettriche e ha dato un colpo alla produzione di energia eolica: a subire in questo caso il contraccolpo maggiore sono state il Regno Unito e l’Irlanda, che comprano parecchia energia dalla Norvegia.
La crisi energetica si è presto allargata: le tensioni sui mercati fornitori del gas naturale si sono estese rapidamente a quelli di petrolio e carbone, che erano rimasti largamente estranei rispetto alla crescita esponenziale del prezzo del gas verificatasi l’estate scorsa.
Per gli esperti del settore, entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2022, la domanda di petrolio arriverà a 100 milioni di barili al giorno: è un ritorno a consumi precedenti alla pandemia (nel 2019 se ne consumavano 99,7 milioni al giorno secondo i dati dell’Agenzia internazionale dell’energia) che ha fatto aumentare molto i prezzi, anche a causa della riluttanza dei paesi esportatori ad aumentare la produzione. Il prezzo del Brent, il petrolio del mare del Nord, ha raggiunto un valore che non aveva da tre anni: il 4 ottobre ha superato gli 81 dollari al barile.
Con un prezzo dei combustibili che, per chi non ha stipulato contratti a lungo termine, è più che triplicato nel giro di un anno, molte imprese nel mondo, in Italia e in Europa rischiano oggi blocchi temporanei per risparmiare sulle forniture.
Unione Europea in cerca di soluzioni comuni
A fine ottobre la riunione straordinaria del Consiglio energia dell’Unione europea sulla corsa record dei prezzi dell'elettricità e del gas si è risolta in un nulla di fatto dato che non è emersa una posizione comune circa gli interventi da prendere a livello comunitario.
Una delle proposte oggi sul tavolo, azzoppata dal blocco dei Paesi del Nord, è la creazione di un sistema di stoccaggio comune di gas. Nel suo intervento il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha puntualizzato: “Accogliamo con favore l’intenzione della Commissione europea di lavorare su regole che definiscano le modalità operative a livello europeo per la gestione degli stoccaggi, secondo modelli regolati basati su norme di mercato. Inoltre, nell'attuale quadro di grande aumento dei prezzi, deve essere tenuto in considerazione l'impatto sulla sicurezza degli approvvigionamenti, visto che il gas naturale comunque svolgerà ancora un ruolo significativo nella transizione energetica”. Il titolare del Mite ha poi dichiarato che l'Italia è favorevole a investire nella ricerca e innovazione per le fonti rinnovabili, lo stoccaggio e tutte le tecnologie emergenti.
Per il momento, però, gli Stati membri continueranno a tamponare l’emergenza da soli, almeno fino al prossimo appuntamento di dicembre in occasione dell'ultimo consiglio europeo prima della fine dell’anno. Nell’attesa però la preoccupazione resta elevata: c’è un rischio di un lockdown energetico? Per ora, per quanto cercare di limitare i consumi di energia possa avere un impatto positivo sia in termini di bolletta che sull’ambiente, l’eventualità di una drammatica interruzione delle forniture sembra essere ancora lontana.
L'impatto sulle bollette di luce e gas
L’Italia ha già preso misure a livello nazionale per mitigare l'impatto dei rincari dei prezzi energetici sulle categorie più vulnerabili e ha riserve di gas superiori a quelle della media Ue. Come ha ribadito nel mese di ottobre il ministro Cingolani, “Il sistema italiano di approvvigionamento del gas naturale – ha aggiunto - è storicamente il più diversificato d’Europa e questo ci dà un po’ più di libertà, in particolare con cinque gasdotti di importazione alimentati da produzioni provenienti principalmente da Russia, Algeria, Nord Europa, Libia e Azerbaigian. L’Italia può contare su una produzione nazionale che fornisce circa il 10% dei consumi interni annui e su tre rigassificatori. Inoltre, il sistema italiano è dotato di un discreto numero di siti di stoccaggio che garantiscono, specialmente durante i periodi invernali in cui la domanda è più elevata, la sicurezza della fornitura giornaliera coprendo i picchi di richiesta”.
Sul fronte dei prezzi però le notizie non sono buone: lunedì 8 novembre il prezzo del gas naturale è tornato ad aumentare in Europa. È cresciuto quasi del 10 per cento, superando gli 80 euro per megawattora per poi fermarsi a 76,50. Il 5 ottobre era arrivato a 117,50 euro per megawattora, il 400 per cento in più rispetto all’inizio dell’anno. Stando alle previsioni dell’Authority per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera), affinché, invece, i prezzi del gas naturale si riallineino tra i 30 e i 40 euro/MWh si dovrà attendere il 2023. In sintesi, il problema è destinato a durare per tutto il prossimo inverno, fino a primavera inoltrata del 2022.
“Dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020”, ha spiegato il presidente dell’Authority Stefano Besseghini nella sua Relazione annuale al Parlamento”, l’attivarsi della ripresa economica con l'inizio del 2021 ma soprattutto l'evidenza della efficacia della campagna vaccinale hanno determinato una brusca accelerazione in tutti i costi delle materie prime, con variazioni che nel giro di pochi mesi li hanno proiettati decisamente verso massimi storici. È facile prevedere che la pressione al rialzo dei prezzi si mantenga nell’immediato futuro e le previsioni di medio periodo lasciano ad oggi intravedere un processo molto lento di riallineamento a prezzi più bassi".
Secondo Besseghini per un calo dei prezzi del gas è necessaria una diversificazione dell'approvvigionamento e un investimento nelle infrastrutture. Ma la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili non sarà una questione di pochi anni, bensì un lungo e difficile percorso tutto in salita.




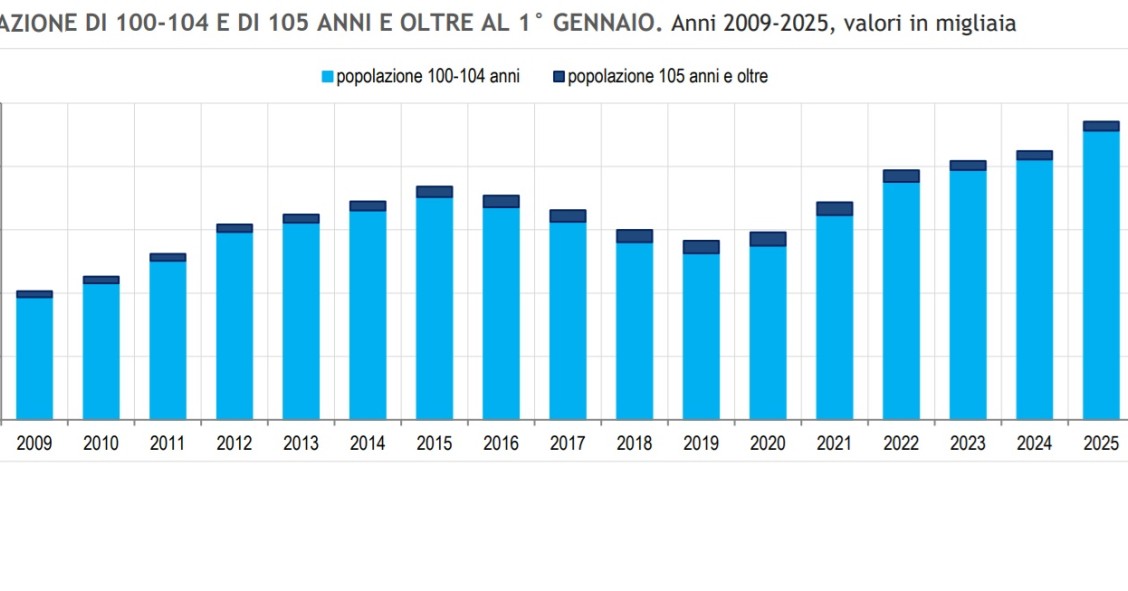



per commentare devi effettuare il login con il tuo account